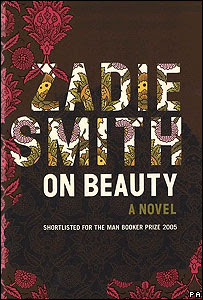Vecchio film di Woody Allen, non ricordo il titolo. In un galleria d’arte contemporanea nel bel mezzo di Manhattan, l’occhialuto protagonista si avvicina a un’intellettuale solinga che sta mestamente considerando un quadro inguardabile, e le chiede se ha programmi per venerdì sera. “Venerdì sera penso di suicidarmi”, fa quella. “E sabato sei libera?”.
Vecchio film di Woody Allen, non ricordo il titolo. In un galleria d’arte contemporanea nel bel mezzo di Manhattan, l’occhialuto protagonista si avvicina a un’intellettuale solinga che sta mestamente considerando un quadro inguardabile, e le chiede se ha programmi per venerdì sera. “Venerdì sera penso di suicidarmi”, fa quella. “E sabato sei libera?”.mercoledì 30 maggio 2007
Non è bene che l'uomo sia solo
 Vecchio film di Woody Allen, non ricordo il titolo. In un galleria d’arte contemporanea nel bel mezzo di Manhattan, l’occhialuto protagonista si avvicina a un’intellettuale solinga che sta mestamente considerando un quadro inguardabile, e le chiede se ha programmi per venerdì sera. “Venerdì sera penso di suicidarmi”, fa quella. “E sabato sei libera?”.
Vecchio film di Woody Allen, non ricordo il titolo. In un galleria d’arte contemporanea nel bel mezzo di Manhattan, l’occhialuto protagonista si avvicina a un’intellettuale solinga che sta mestamente considerando un quadro inguardabile, e le chiede se ha programmi per venerdì sera. “Venerdì sera penso di suicidarmi”, fa quella. “E sabato sei libera?”.martedì 29 maggio 2007
Il diavolo con le scarpe da tennis
 Di James Robertson in Italia non è mai stato tradotto nulla. Eppure nel mondo anglofono ha esordito sette anni fa, pubblicando due romanzi (The Fanatic nel 2000 e Joseph Knight nel 2003), il secondo dei quali – come non so per scienza infusa ma apprendo dalla biografia in terza di copertina – ha dato il la a una impressionante sfilza di riconoscimenti letterari. Ora, per quanto si debba sempre considerare che in Gran Bretagna vengono assegnati più premi di quanti libri si pubblichino, e si debba di conseguenza tarare il successo conseguito da Robertson (che la foto in bianco e nero mostra relativamente giovane e decisamente ridanciano) notando che i suoi onori sono sempre stati limitati alla nativa Scozia senza mai invadere il resto della Gran Bretagna, non ho potuto fare a meno di notare che nelle librerie di Oxford le pile del suo ultimo romanzo, The Testament of Gideon Mack (ora in edizione Penguin), calano abbastanza rapidamente e necessitano sempre di un rimbocco. Significa che anche al di fuori dei confini patri la gente lo compra, probabilmente lo legge, presumibilmente ne parla bene ad altra gente che a sua volta lo compra – e così via col grande ciclo della vita editoriale. Ragion per cui ho allungato la mano verso la pila e ne ho comprato una copia anch’io.
Di James Robertson in Italia non è mai stato tradotto nulla. Eppure nel mondo anglofono ha esordito sette anni fa, pubblicando due romanzi (The Fanatic nel 2000 e Joseph Knight nel 2003), il secondo dei quali – come non so per scienza infusa ma apprendo dalla biografia in terza di copertina – ha dato il la a una impressionante sfilza di riconoscimenti letterari. Ora, per quanto si debba sempre considerare che in Gran Bretagna vengono assegnati più premi di quanti libri si pubblichino, e si debba di conseguenza tarare il successo conseguito da Robertson (che la foto in bianco e nero mostra relativamente giovane e decisamente ridanciano) notando che i suoi onori sono sempre stati limitati alla nativa Scozia senza mai invadere il resto della Gran Bretagna, non ho potuto fare a meno di notare che nelle librerie di Oxford le pile del suo ultimo romanzo, The Testament of Gideon Mack (ora in edizione Penguin), calano abbastanza rapidamente e necessitano sempre di un rimbocco. Significa che anche al di fuori dei confini patri la gente lo compra, probabilmente lo legge, presumibilmente ne parla bene ad altra gente che a sua volta lo compra – e così via col grande ciclo della vita editoriale. Ragion per cui ho allungato la mano verso la pila e ne ho comprato una copia anch’io.lunedì 28 maggio 2007
Recensire la stagione
1. La sorpresa Poche chiacchiere, l’impresa di quest’anno l’ha fatta la Reggina. Partire con 15 punti di penalizzazione avrebbe steso un bue, e peggio ancora segnare tre goal alla prima partita e perderla. La bravura (conclamata) di Mazzarri è stata di essere riuscito a tenere saldo un gruppo che, per quanto privo di primi violini, ha dato risultati insperati non solo in termini di punti ma anche come efficienza: con 52 reti segnate, la Reggina ha avuto il secondo miglior attacco delle squadre finite fuori dal giro europeo, ossia dall’ottavo posto in giù. La salvezza, benché attesa fino all’ultima giornata e benché forse irraggiungibile senza lo sconto di pena (4 punti in più), è stato il premio meritatissimo per una squadra che avrebbe potuto ambire ben altri traguardi; fermo restando che forse, senza la zavorra iniziale, non avrebbe saputo trovare le energie per eccellere. Sempre restando nel campo delle escluse dall’Europa, meglio della Reggina ha fatto solo l’attacco dell’Atalanta, che è anche riuscita a rispolverare Vieri. Una funzionale organizzazione di gioco, qualche bella soddisfazione (il 2-0 sul Milan, il 2-1 sulla Roma, tanto per dire) e un ottavo posto conclusivo niente male per una squadra appena tornata in A. In generale, va notato che tutte le tre neopromosse si sono salvate, più o meno scricchiolando, il che rende l’idea dell’alto livello della Serie B dello scorso anno, e fa ben sperare per quello, ancora più alto, che si annusa per la A dell’anno prossimo.
2. La conferma 97 punti, miglior attacco, distanza siderale dalla seconda e diciassette vittorie una dietro l’altra: solo l’Inter poteva vincere il campionato. In più, ha dimostrato di saper vincere non solo le partite che avrebbe dovuto pareggiare (andata e ritorno con la Fiorentina, tanto per dire), ma anche quelle che era quasi riuscita a perdere (la Supercoppa con la Roma, se ve la ricordate ancora). In più, ha in Ibrahimovic un investimento sicuro per il futuro (se resta dov’è). In più, finalmente Mancini l’ha fatta giocare con formazione e tattiche coerenti, e sugli schermi di San Siro è andato in onda addirittura il ritorno del terzino sinistro. Di meno, invece, l’eccessivo rilassamento nella seconda parte della stagione e il sospetto che senza il terremoto estivo sarebbe arrivata ancora una volta terza - ma c’è tutto l’anno prossimo per dimostrare il contrario.
3. La domanda Il Catania s’è salvato e il Chievo è stato retrocesso; il punto sottratto al Siena per inadempienze finanziarie alla fine non s’è rivelato decisivo, salvandoci forse da un’estate di polemiche che, personalmente, mi sento di rinfocolare così: e se dopo la brutta faccenda al Catania, oltre alla squalifica del campo, fosse stato tolto qualche punticino?
4. La delusione Il Milan, senza se e senza ma. Sia chiaro che mi sto limitando a considerare il campionato, e che nella circostanza al Milan non è riuscito di fare quello che gli era sempre riuscito benissimo (distanziare l’Inter di una decina di punti in un paio di mesi) e di cui Galliani si era detto tanto sicuro quanto lo ero io, rimettendoci peraltro una birra con un amico interista. Ha sbagliato tutta la campagna acquisti estiva ed è dovuto correre ai ripari in gennaio. Ha perso tutti e due i derby, come non avveniva da 25 anni. È stato sconfitto dalla Roma, dal Palermo e dall’Atalanta (Udinese e Reggina oggettivamente non contano): una tragedia. Soprattutto, penalizzazione nonostante, è stato un grave errore focalizzare l’attenzione sul quarto posto come obiettivo massimo: una squadra del genere deve pensare a vincere comunque.
5. La follia Se l’Ascoli è stato retrocesso con una notevole dose di inevitabilità, di sfortuna e soprattutto facendo vedere cose gradevoli (Pagliuca, Eleftheropoulos, Soncin, Bjelanovic, Paolucci), almeno è riuscito a non arrivare ultimo, scavalcando in extremis il Messina che riesce nel record di venire retrocesso in serie B per due stagioni di fila. Temendo che essere richiamati all’improvviso in prima divisione e presentarsi con una squadra inadeguata non fosse sufficientemente temerario, quelli che a Tutto il Calcio Minuto per Minuto vengono chiamati i peloritani hanno provveduto a mettersi in balia dei voleri (isterici) della tifoseria, finendo per richiamare Giordano che era stato cacciato con ignominia poco prima, esonerandolo di nuovo, e facendo nelle ultime 27 giornate meno punti di quanti ne avessero fatti nelle prime 11. Alla stessa maniera, lascia perplessi il costume di richiamare l’allenatore esonerato, messo in voga dal Cagliari e dal Torino, come ad ammettere che se i presidenti (e i tifosi) avessero avuto più pazienza le squadre avrebbero concluso con meno fiatone.
6. Il goleador Questo campionato a 20 squadre non mi piace per niente e continuo ad aspettare che si torni a 16; ma, come previde qualche anno fa il sommo Adalberto Bortolotti, la (metaforica) apertura della frontiera bassa e il conseguente inabissamento del livello medio se non altro portano con sé una maggior facilità di realizzazione per gli attaccanti – non a caso, nell’ipertrofica serie A degli anni ’50, gli attaccanti erano bulimici, si pensi a Nordhal. Quest’anno abbiamo riscoperto Totti, che s’è infilato il pollice in bocca per 26 volte, indorandosi la scarpa e riscattando un Mondiale vinto senza brillare come ci sarebbe piaciuto (per non dire che evidentemente la sua scelta di rinunziare alla nazionale è giustificata dai dati di fatto, e per non dire inoltre che è prolifico non solo sul campo, visto che se continua a questo ritmo lui e sua moglie invertiranno da soli il calo demografico). Però è bello vedere che dietro di lui la classifica marcatori vede un ritorno di attaccanti abituati al fango e alle sterpaglie (Lucarelli, 20 goal; Riganò, 19 goal; Amoruso e Spinesi 17, Rocchi 16), nonché una coppia meravigliosamente viola, Toni e Mutu, che con 16 reti ciascuno ha segnato più della metà di tutti i goal della scintillante Fiorentina.
7. L’anno prossimo Indubbiamente è ancora presto per fare i maghi, ma è prevedibile che l’Inter voglia tentare una volta per tutte di vincere la Champions e magari riaprire, come nei favolosi anni ’60, un ciclo europeo di trionfi milanesi. Questo potrebbe lasciare maggior spazio in Italia: non alla Juventus, che sembra ancora in stato confusionale e farebbe bene a guardarsi sempre le spalle, e forse nemmeno al Milan, che ha bisogno di un po’ di puntelli nonostante che di notte balli sempre elegantemente; ma alla Roma e (giusto dietro) alla Fiorentina, che hanno fatto vedere il miglior calcio dell’anno, che hanno due allenatori fenomenali che iniziano a mantenere tutto ciò che promettevano e che hanno bisogno soltanto di riserve più solide per diventare grandi.
Piove sui giusti e sugli inglesi
Qualche santo particolare? No. Il ricordo di una data storica? No. Il compleanno del vicino di casa del giornalaio di un compagno di scuola del pronipote della Regina? Macché: in Inghilterra oggi è festa perché è lunedì.
Sia chiaro, questo non accade ogni settimana, altrimenti sarebbe una pacchia; ma la vita da queste parti prevede che nel corso dell’anno alcuni lunedì, accuratamente scelti a cazzo di cane, siano bank holidays ovvero giorni in cui gli uffici restano chiusi, i negozi adottano orario ridotto, i supermercati hanno gli scaffali semivuoti e in cui ovviamente piove. Nell’anno del Signore 2007, in Inghilterra (e in tutto il Regno Unito) è festa il 19 marzo, il 9 e il 23 aprile, il 7 e il 28 maggio (oggi, per chi fosse particolarmente distratto), il 27 agosto e basta. Si tratta di sei date selezionate con l’unico criterio di seguire una domenica, e di consentire agli indigeni di divertirsi bevendo un giorno di più e dormendo una mattina ancora.
Per questo piove – come ho capito due ore fa, quando per andare a fare colazione ho dovuto noleggiare un canotto. Infatti dovete sapere che nel Dizionario Filosofico, a suo tempo, Voltaire inserì un articolo dedicato alle leggi civili ed ecclesiastiche; nel quale si lamentava che i contadini della sua tenuta, in quanto cattolici, erano tenuti a non lavorare in ogni festa religiosa, a parte le domeniche, causando così a sé stesso, alla tenuta e alla nazione una perdita di denaro che lui quantificava in non ricordo più quanti soldi. La soluzione che Voltaire proponeva era che lo Stato prendesse in mano la situazione, eliminando ogni festa che non costituisse il consueto e debito riposo settimanale, che consente di riprendere il lavoro della settimana successiva con maggior baldanza.
L’Inghilterra, ovviamente, l’ha fatto. A queste latitudini un cattolico deve rassegnarsi alla consapevolezza che l’Epifania, Ferragosto (Assunzione della Vergine), Ognissanti e l’Immacolata siano giorni feriali, e che la commemorazione religiosa sia ridotta a una sfilza di normali (rispettivamente, quest’anno) sabato, mercoledì, giovedì e ancora sabato. Si tratta di quattro giorni che sono stati gloriosamente ricuperati al lavoro, al guadagno e alla laicità. Per non parlare delle feste patronali: io, per quanto distante possa trovarmi da Gravina, ho seguitato a festeggiare il 29 settembre (San Michele Arcangelo) andando a messa e poi sbevazzando con gli amici. Perfino il giorno di Pasqua, come ricorderanno i più nullafacenti fra i miei lettori, con annesso Lunedì dell’Angelo è stato voltato a bank holiday weekend, ossia niente più a che vedere con la religione bensì solo e soltanto con questo lunedì pendulo, vuoto e ovviamente piovoso.
Il diabolico tentativo, neanche tanto larvato, è di sterilizzare l’anima dei sudditi di Sua Maestà, nascondendo le date significative (6 gennaio, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre) e sostituendole con lunedì a capocchia (“Sua Maestà la Regina si pregia di comunicarvi che al mattino del 28 maggio sarete dispensati dall’utilizzo della sveglia”), nei quali far finta che sia domenica, far festa, uscire con gli amici e andare a sdraiarsi nei campi. Al che Domineddio, che evidentemente non è anglicano, fa piovere ininterrottamente per tre giorni, e gli inglesi rimpiangono di non stare in ufficio.
venerdì 25 maggio 2007
Lo scudetto dove lo metto?
[Sono passate più di trentasei ore ma Gurrado è ancora irreperibile; fonti attendibili lo danno impegnato a correre esultante per il centro di Oxford, vestito soltanto di un vecchio polsino rossonero. In sua sostituzione, pubblichiamo l’intervento di un ragionevole ed equilibrato corsivista nerazzurro che ha preso temporaneamente possesso della sua tastiera.]
Il Milan ha dimostrato ancora una volta i propri limiti concedendo al Liverpool di segnare a un minuto dalla fine; e solo l’arbitro Herbert Fandel, il De Santis tedesco, ha consentito di camuffarli troncando anticipatamente i minuti di recupero dopo una pronta telefonata congiunta di Leonardo Meani, Tiziano Crudeli e Bobo Maroni, abilmente celati in una cabina telefonica di Platìa Mounastiraki, nel pittoresco quartiere della Plaka. Se avesse fischiato venti secondi dopo, il Liverpool avrebbe avuto tutto il tempo di segnare due o tre volte inframezzando ogni goal con reiterati giri di campo, coreografici balletti e fuochi d’artificio, privando il Milan di una vittoria in fin dei conti immeritata e stabilendo una volta per tutte qual è la squadra più forte del mondo, cioè l’Inter.
È evidente che la Champions League è una competizione minore. Per vincerla al Milan è bastato superare il Bayern Monaco, il Manchester United e il Liverpool, mentre l’Inter ha dominato la serie A surclassando negli scontri diretti il Palermo, contenendo la grintosa risalita dell’Empoli e mettendo il sigillo definitivo sul campo del Siena. Per non dire quant’è difficile confermarsi: il Milan non arrivava in finale di Champions League da un’eternità, due anni, e non la vinceva da due eternità, ovvero quattro anni. Al contrario, l’Inter domenica prossima festeggerà il suo secondo scudetto consecutivo, aggiungendo trionfo a trionfo quando ancora sono negli occhi di tutti le spettacolari immagini del momento decisivo dello scorso anno: la riunione fra Guido Rossi, già membro del consiglio d’amministrazione dell’Inter, e Guido Rossi, al contempo ex e futuro presidente di Telecom (azionista dell’Inter e sponsor del campionato), per ottenere il via libera all’assegnazione dello scudetto da parte di Guido Rossi, commissario straordinario della Federcalcio.
Inoltre sono stato molto infastidito dalla vergognosa scena dei giocatori del Milan che, disposti su due file, sbeffeggiavano il Liverpool applaudendo coram populo gli avversari sconfitti; che significativa distanza con la corsa irrefrenabile di Julio Cruz e compagni a Valencia per complimentarsi con i vincitori, stringere loro la mano e porgere l’altra guancia! La classe, la sportività, l’eleganza non sono cose che si imparano in una notte: così alla demagogia sfrontata di Berlusconi, il quale ha parlato di “grande successo per Milano” e ha concluso addirittura con un “viva il Milan e viva l’Inter”, noi rispondiamo con l’aristocratico gesto dell’ombrello mediante il quale durante il derby Massimo Moratti ha salutato il ritorno in Italia di Ronaldo, uno dei più grandi campioni della storia, al quale l’Inter deve gli scudetti del 1998 e del 2002, che le verranno assegnati quest’esate per soprammercato. E gli allenatori, poi: come si fa a dire che Carlo Ancelotti, con due Champions League e uno scudetto (peraltro nemmeno consegnato a tavolino), abbia vinto più di Roberto Mancini il quale nel suo palmarès può vantare la Coppa Italia, e la Coppa Italia, e la Coppa Italia, eccetera?
Sarò facile profeta dicendo che poco resterà nell’immaginario collettivo dei due goal irregolari di Inzaghi (il primo segnato abbrancando il pallone con due mani, ficcandoselo sotto l’ascella e correndo nella porta del Liverpool dopo aver infilato un dito nel naso del portiere; il secondo in evidente posizione di fuorigioco, poiché al momento del passaggio di Kakà le immagini inequivocabili di Inter Channel mostrano Inzaghi che sta scavalcando la pista di atletica per precipitarsi in curva urlando “Parakalò, parakalò”), a differenza dei quattro goal con cui, due all’andata e due al ritorno, l’Inter ha dominato la Roma nella finale di Coppa Italia, non riuscendo a vincerla soltanto per il disonesto maneggio di far iniziare la partita dell’Olimpico alle 17 senza dirlo all’Inter che s’è doverosamente presentata in campo, come da accordi pregressi, alle 21. Ma la Roma ha ben poco da vantarsi, poiché nel decisivo scontro in campionato l’Inter ha regolata perdendo 1-3, che è la metà esatta di 2-6; e in generale concedendo all’unica squadra che ha ardito contenderci la vittoria in campionato di segnare solamente 13 goal in cinque partite.
Una curiosa e fortunata coincidenza vuole che il computer sul quale sto scrivendo, per via di una perversa correzione automatica, sostituisca ogni volta al nome di Inzaghi il termine indaghi: si tratta di una prefigurazione e di una profezia di quello che avverrà quest’estate, quando un pool investigativo composto da Elio Corno, Evaristo Beccalossi ed Enrico Bertolino, capitanato da Francesco Saverio Borrelli e dal Cardinal Martini, renderà pubbliche delle foto di Carlo Ancelotti che si accende di nascosto una MS pur avendo fatto voto di smettere di fumare in caso di vittoria sul Liverpool: il che porterà alla revoca della vittoria del Milan in Champions, all’obbligo di giocare tutte le partite casalinghe della prossima stagione sul campo di Novosibirsk e utilizzando una palla medica, al ritiro della laurea conseguita dal figlio di Galliani e alla sostituzione del termine “Silvio Berlusconi” col termine “Alfonso Pecoraro Scanio” in tutti gli atti della scorsa legislatura; all’estradizione di Ronaldo e all’ergastolo per Carlo Pellegatti; nonché, con prevedibile effetto domino, alla fucilazione di Alessandro Del Piero e alla cottura del suo uccellino, alla retrocessione in serie inferiore di Roma, Lazio, Fiorentina, Chelsea, Manchester United, Bayern Monaco, Sporting Lisbona, Ajax, Real Madrid, Barcellona e Sassari Torres; alla conseguente assegnazione all’Inter di tutte le edizioni finora disputate di Champions League, Coppa Uefa, Intertoto, Torneo Anglo-Italiano, Coppa Carnevale, Memorial “Adolf Hitler”, Sei Nazioni, America’s Cup, Tour de France, Ordine della Giarrettiera, Premio Nobel per la Matematica (appositamente istituito) nonché di svariate puntate, mai trasmesse, de La Prova del Cuoco.
Insomma il Milan avrà pur vinto questa settima Champions League, la quinta con Paolo Maldini e fregnacce varie, ma ci sono tutte le premesse perché l’anno prossimo al Trofeo Tim sia tutta un’altra storia; a meno che non lo vinca di nuovo la Juventus.
mercoledì 23 maggio 2007
Il gioco dell'otto
Avevo otto anni e al primo goal di Gullit andò via la luce. O meglio, la luce scelse di andare via un attimo prima che ci fosse il goal, fulminandoci sull’immagine di lui che, avanzato sornione verso il centro dell’area, muoveva senza sforzo apparente la gamba destra per accompagnare la palla nella porta sguarnita dello Steaua; lasciandoci incerti se il goal fosse veramente diventato un goal (ma certo che era un goal, la porta era vuota, la palla andava dritta dentro) e al contempo certissimi che con un colpettino, piano piano, a porta vuota, Gullit aveva cambiato l’inerzia della partita, del Milan, della mia esistenza e della storia tutta.
(Barcellona, 24 maggio 1989: Milan 4 – Steaua Bucarest 0)
Avevo nove anni e il Benfica fu un pensiero che mi assalì d’improvviso, nel tardo pomeriggio, tornando a casa dal catechismo. Il tempo di citofonare era stato lo spartiacque fra la giornata comune (la scuola, il pranzo, la chiesa) e la giornata particolare, unica, cioè la finale; e, al contempo, il nanosecondo in attesa che mi venisse aperto il portone già mi aveva fatto capire che la finale non era unica perché era una replica dell’anno prima, e non era una replica perché ogni volta è un’emozione, anzi un terrore a sé stante, che con maggiore o minore resistenza si trascolora in vittoria.
(Vienna, 23 maggio 1990: Milan 1 – Benfica 0)
Avevo dodici anni e imparai la tragedia. Nell’intervista poco prima della partita, già sul campo di Monaco, Berlusconi aveva dichiarato che era come aspettando un figlio: sono tutti importanti ma dopo il primo il nervosismo cala inevitabilmente, diventa consuetudine. Figuriamoci il terzo, pensai, tanto più che ero forte dei due esempi precedenti grazie ai quali, qualsiasi cosa accadesse, quale che fosse l’avversario definitivo che si andava a scoprire, alla fine vinceva sempre il Milan con la sua bianca maglia di riserva. Mi sedetti tranquillo e li vidi entrare in campo vestiti di rosso e nero.
(Monaco di Baviera, 26 maggio 1993: Milan 0 – Olympique Marsiglia 1)
Avevo tredici anni, avevo pochi brufoli e avevo paura del Barcellona. Iniziavo a capire di calcio più di quanto lo amassi, e per guardare una partita ci mettevo più cervello che trasporto, passaggio che segna definitivamente la fine dell’infanzia, un po’ come quando si capisce che Babbo Natale non esiste e che quindi i regali provengono da Gesù Bambino. Ovviamente, nell’occasione, il cervello non era mio ma dei vari opinionisti i quali a loro volta non facevano che riportare le opinioni di Crujff, persona che non ha mai brillato per umiltà (avendone ben donde, peraltro) e che all’epoca allenava il Barça, quindi era vagamente di parte. Per la prima volta, distintamente ricordo di aver accettato a priori l’eventualità della sconfitta e di aver perfino dichiarato che tanto valeva guardare su Rai3 la diretta del voto di fiducia alla Camera al governo, tanto per restare in argomento, Berlusconi. Prima di pranzo, sul pullman che mi riportava a casa, un compagno di scuola disse: “Secondo me, se Zubizarreta non è in giornata, possiamo anche fargliene tre o quattro”; scendendo, risposi: “Ma va’”.
(Atene, 18 maggio 1994, Milan 4 – Barcellona 0)
Avevo quattordici anni e fingevo di collaborare a una rete televisiva locale. Nutrendo una smodata passione per il Milan, e facendo ben poco per tenerla nascosta, un’ora prima del telegiornale delle otto (edizione di quasi cinque minuti) mi avevano dato libera uscita per prepararmi in santa pace alla visione, esprimendo parimenti un intrinseco commento sulla mia utilità in loco. Ne approfittai ben felice, con l’ottimismo dei ginnasiali, contando sul fatto che se avevamo massacrato il Barcellona potevamo ben superare l’Ajax, che per quanto siano scricchiolanti le premesse alla fine il bene (cioè il Milan) vince sempre e soprattutto che stando a fonti certe avremmo di nuovo giocato in bianco. Iniziai a festeggiare e accesi la tv.
(Vienna, 24 maggio 1995, Milan 0 – Ajax 1)
Avevo ventidue anni e non ci speravo più: le finali mi sembravano un ricordo lontano, confinato all’infanzia all’adolescenza e agli anni trascorsi a Gravina. Tanto per dire, per l’università mi ero trasferito a Pavia da cinque anni e nella circostanza specifica ero a Roma da un amico, milanista anche lui; per non intristirci guardando la partita da soli, ammalati entrambi dello stesso scetticismo, avevamo raggiunto altri cinque o sei amici a casa loro. Tutti, tutti juventini. Dopo pochi minuti io e il mio amico urlammo perché avevano annullato un goal a Shevchenko. Nell’intervallo mangiammo un’ottima e abbondante insalata di riso. Subito dopo urlarono gli juventini per una traversa di Antonio Conte. Ai rigori, gentlemen’s agreement, patto fra gentiluomini: qualunque cosa fosse accaduta, ma proprio qualunque, compresi l’invasione degli ultracorpi e il diluvio universale, tutti ma proprio tutti avremmo conservato il silenzio per rispetto della sofferenza altrui, milanisti e juventini. Non una parola: e alla fine mi trovai a urlare con il mio amico, chiuso nel bagno di una casa nella quale ero entrato per l’unica volta nella mia vita.
(Manchester, 29 maggio 2003, Milan 0 – Juventus 0, poi 3-2 ai rigori)
Avevo ventiquattro anni e ci avevo fatto l’abitudine. Buona parte dei miei amici modenesi l’avevo conosciuta guardando con loro le partite dei turni precedenti e alternando le presentazioni vicendevoli a salaci commenti sulla discutibile creatività di Serginho. Dovendo guardare la partita in una sala tv pubblica, mi ero garantito la prima fila sistemandovi il mio deretano un’ora prima del calcio d’inizio, e bene avevo fatto perché mi sarebbe bastato arrivare con cinquanta secondi di ritardo, poniamo, e non avrei visto il primo goal di Maldini in sette, e dico sette, finali di Coppa dei Campioni. Avrei anche potuto andarmene fra il primo e il secondo tempo, poniamo, dopo che al goal del 3-0 avevo percorso la distanza fra me e la tv strisciando sulle ginocchia come davanti a una reliquia, quando uno dei vari interisti che mi capita di conoscere mi apostrofò: “Congratulazioni, ormai…”; e io: “Aspettiamo i supplementari.”
(Istanbul, 25 maggio 2005, Milan 3 – Liverpool 0, no, Milan 3 – Liverpool 3, poi 2-3 ai rigori)
Ho ventisei anni e sono a Oxford da due mesi.
(Atene, 23 maggio 2007, Milan – Liverpool).
lunedì 21 maggio 2007
Il ciclismo è metafisico
Nel 2004 vivevo a Napoli e, avendo la fortuna di avere fra le varie una coinquilina maschilista la quale riteneva che al fine settimana la donna dovesse sfaccendare e l’uomo riposarsi, indipendentemente dall’evenienza che l’uomo (nel caso specifico, io) non avesse faticato gran che durante la settimana, e altresì indipendentemente dall’evenienza che io (nel caso specifico, uomo) fossi o meno d’accordo con questa veduta – dicevo, nel 2004 vivevo a Napoli e al sabato e alla domenica il mio principale impegno era leggere la Gazzetta dello Sport, altrimenti la mia coinquilina si arrabbiava e diceva che non mi riposavo abbastanza. Non sia mai.
Nel 2004 vivevo a Napoli (come forse avrete capito) e nutro un distinto ricordo delle Gazzette che scandivano i fine settimana nonché l’indegna propaggine del weekend che a Napoli andava dal lunedì successivo al venerdì precedente. Nel 2004 vivevo a Napoli ed è stato un lunghissimo weekend sommerso di pagine rosa, mentre la mia coinquilina mi chiedeva di sollevare i piedi per consentirle di dare una lavata a terra.
A farla breve, nel 2004 vivevo a Napoli – questo è sufficientemente appurato – e un sabato mattina, non avendo altro da fare che leggere la Gazzetta dello Sport, ho trascorso una buona mezz’ora a soppesare un’intervista a Piersilvio Berlusconi, nella quale veniva notificata con non poco orgoglio l’ideazione di un reality show sul mondo del calcio, il primo reality show sportivo, etc. etc. I risultati si sono visti: nel 2005 e nel 2006 vivevo a Modena e a lungo andare perfino i più sfaccendati fra i miei amici (taluni sfaccendati quasi quanto me) si sono annoiati a guardare Campioni; ma nel 2004 vivevo a Napoli e pur senza avere la palla di vetro decretai ad alta voce e aprioristicamente che questo reality show calcistico non sarebbe andato da nessuna parte. La mia coinquilina, benché anglocanadese e interessata soprattutto all’hockey su ghiaccio e a Salvator Rosa, per fare conversazione mi chiese perché.
Perché il calcio si basa esso stesso sulla struttura del reality; ci sono prove, eliminazioni, alterni destini; perché dall’avvento di Sky e prima ancora Telepiù la telecamera non ha più confini che la trattengano; perché anche prima, ma prima prima prima, quando ci si limitava ad ascoltare la radio due ore a settimana, c’era un filo che legava il tifoso alla squadre e a ogni singolo calciatore (esattamente, come nella pubblicità della Ford) sette giorni su sette. Quindi l’idea stessa di Campioni zoppicava da principio perché sarebbe arrossita tentando di rispondere alla domanda: “Se già mi emoziono alla sola idea che esista Gigi Buffon, se trepido a ogni bollettino medico su Maradona, se mi sento un pezzo in meno alla morte di John Charles e ancora mi commuovo a vedere vecchie foto di Alviero Chiorri (baffuta mezzala della Cremonese dal 1984 al 1992), che [minchia di] bisogno c’è di creare una squadra di calcio dal nulla appositamente per farmi sforzare di affezionarmi a – come avrei poi appreso che si sarebbero chiamati – Rocca, Calanchi e Bertaccini?
Nel 2004 vivevo a Napoli e questo è grossomodo stato il discorso che (a parte la parola che ho racchiuso fra parentesi quadre) ho espletato mentre la mia coinquilina eliminava i fondi del caffè. Se la mia coinquilina non fosse stata una storica dell’arte canadese (nel senso di storica canadese dell’arte) bensì un rugbista di Civitavecchia avrei avuto sicuramente modo di essere più convincente. Fortuna vuole che nel 2004 vivevo a Napoli anche con un rugbista di Civitavecchia (non avevo più case, avevo più coinquilini), col quale talvolta festeggiavo il sabato andando a mangiare untissime tracchie da Nennella (Trattoria “da Nennella” – Via Lungo Teatro Nuovo, 103– ovviamente Napoli – guai a chi non ci va) così da poter fare al riguardo un discorso più articolato e convincente. Non sul calcio, però, sul ciclismo.
Nel 2004 vivevo a Napoli e non avevo il televisore, evenienza che trovo tragica in generale e maggiormente quando c’è il Giro d’Italia. Io e il rugbista di Civitavecchia, quando c’erano le tappe importanti, andavamo a nasconderci in un bar vicino al posto in cui eravamo pagati per stare, sperando che nessun collega passasse di lì e ci scoprisse a contare pedalate, battiti al minuto, chilometri e pendenze. Nel 2004 vivevo a Napoli e in un bar di Via San Sebastiano, alle quattro di un pomeriggio, ho scoperto Damiano Cunego e ho avuto la netta sensazione che avrebbe vinto anche pedalando al contrario. Nel 2004 vivevo a Napoli e mi svegliavo presto, andavo a fare colazione in un bar/pasticceria dietro casa (dove caffè e cornetto insieme costavano un euro) e coi soldi risparmiati mi compravo la Gazzetta dello Sport, a meno che non sapessi che l’aveva già comprata il rugbista di Civitavecchia. Solo una volta, nel 2004 a Napoli, in casa mia entrarono due copie della Gazzetta dello Sport, comprate indipendentemente da me e dal rugbista, poiché nessuno dei due voleva correre il rischio di rimanerne senza. In copertina c’era Cunego e Cunego era un fenomeno.
Cunego era un fenomeno e un miracolo, perché tre mesi prima avevo bussato alla porta della camera vicino alla mia per dire al mio coinquilino rugbista che era morto Pantani. Senza televisione e senza internet, avevamo trascorso la serata fino all’una di notte ad ascoltare la traballante radiolina che mi ha seguito in tutti i miei spostamenti prima di crepare a Modena qualche mese fa. Pantani non c’era più: non c’era più il ciclismo? Valeva la pena? Vedere gente che suda in bicicletta per elaborare il lutto? Tre mesi dopo, alle quattro del pomeriggio, in un bar di Via San Sebastiano io e il rugbista avevamo risposto che ne valeva la pena, ancora.
Perché se il calcio è un reality (e quindi non avrebbe avuto senso fare un reality sul calcio), il ciclismo è metafisico, e quindi non c’è modo di liberarsene. Vedere Cunego che avrebbe vinto il Giro anche saltellando sulla ruota posteriore della sua bici non stimolava tanto l’ammirazione per l’atto sportivo in sé, ma consolava dello spreco di Pantani. Era un’altra delle infinite storie accumulate in anni e anni di interminabili pomeriggi, a guardare corse piatte in cui sembrava non succedesse nulla e invece – e invece – erano il malto che ci consentivano di voler bene a ciascuno di loro, a Zulle che non sapeva fare le discese, a Breukink che era finito in un fosso, a Leblanc che aveva una gamba più corta dell’altra, a Perini che non aveva mai vinto una corsa, a Olano che vinse il mondiale con una ruota a terra, a tutti. Di ricordare il furgoncino contromano sulle strade di Atene (1996), il gatto che taglia la discesa del Chiunzi (1997), il signore vestito da diavolo (tutti i Tour de France da che io ho una memoria cosciente), e così via in eterno.
Il ciclismo, soprattutto, è metafisico perché mette l’uomo di fronte ai suoi limiti. Non dico solo le salite, la fatica, quelle sono parte del gioco. Il ciclismo è metafisico perché non puoi staccartene per il resto dell’anno e nessuna corsa finisce col traguardo. Nel 2003 vivevo a Pavia e un giorno arrivò il Giro d’Italia; dopo la premiazione, nel casino generale, incrociai Antonio Salutini (per gli ignoranti in materia, è un importante direttore sportivo) e prima ancora di spiegargli chi ero e cosa volevo gli chiesi come stava Cipollini. Qualche giorno prima Cipollini era caduto male e a me non interessava sapere se e quando sarebbe tornato a correre, o come sarebbero stati adattati i suoi allenamenti, o se sarebbe cambiata la tattica dei suoi rivali, mi interessava Cipollini come persona; la caduta aveva mostrato un limite, volevo sapere come stava per capire come stava fronteggiando il limite. Salutini rispose lasciando intendere che glielo chiedevano tutti – non gli chiedevano del corridore, gli chiedevano dell’uomo.
Il ciclismo mette l’uomo di fronte ai suoi limiti ed è il motivo per cui, se ci avete fatto caso, in qualsiasi altro sport si spera nella sconfitta dell’avversario mentre quando passa una corsa ciclistica si battono le mani senza distinzione, dal primo all’ultimo, e si battono le mani istintivamente. Accade per due motivi: primo perché, a furia di guardarli, li conosciamo tutti, e quelli che ancora non conosciamo siamo curiosi di conoscerli e capire dove possono arrivare e decifrare che persona sono, come reagiranno alla vittoria e alla sconfitta (nel 1998 una tappa partì da Matera e io rincorsi Missaglia per chiedergli se avesse visto Bugno, con la stessa confidenza con cui avrei chiesto alla coinquilina canadese se avesse visto il rugbista di civitavecchia; Missaglia senza batter ciglio rispose che era ancora in pullman, come la coinquilina canadese avrebbe risposto che era ancora in doccia). Poi perché, ed è più importante, l’avversario del ciclista è fuori dalla corsa, non si tratta di un altro ciclista ma dell’istinto a mettere il piede a terra, a piegarsi sul sellino a piangere perché non si riesce più ad andare avanti (Stéphane Heulot in maglia gialla, Tour de France 1996, settima tappa), a non allenarsi d’inverno e mangiare come un porco (Jan Ullirch tutti gli anni), a stringere verso le transenne e, ovviamente, a doparsi. Se il ciclismo iniziasse e finisse con la corsa, chi cade, chi cede, chi si dopa sarebbe uno sconfitto, un fallito e un reprobo; ma il ciclismo dura in eterno, giorno dopo giorno, e tutti i tifosi spingono ogni corridore nella continua lotta contro sé stesso.
Nel 2004 vivevo a Napoli e da allora un filo metafisico mi lega a Damiano Cunego, che avrebbe vinto il Giro anche in monociclo; lui non sa nemmeno che esisto ma io so della musica che ascolta, del matrimonio, della bimba, della mononucleosi, di tutti i suoi santi giorni. Lui non sa nemmeno che esisto, ma sa che quando sale sulla bicicletta io sono lì a spingerlo, e con lui tutti gli altri prima durante e dopo di lui, e con me qualsiasi tifoso, dovunque, comunque, sempre.
(A questo punto la scena prevede che mi telefoni il mio biografo di corte e mi chieda: “Scusa Gurrado, ma dove vivevi tu nel 2004?” “A Napoli, mi pare.” “Ah. Chissà che mi credevo.”)
venerdì 18 maggio 2007
Attenzione capolavoro
 Prima stavo lavando le mutande (a cosa mi sono ridotto) e m’è tornato in mente un episodio risalente a parecchi anni fa – grossomodo, a occhio e croce, alla seconda liceo (classico) – in cui una compagna di classe avendo saputo che io in futuro avrei gradito fare lo scrittore di professione (speranza che mai come negli ultimi tempi è stata ridotta a fuoco fatuo) mi aveva chiesto, appunto, come si facesse a scrivere. Risposta: “Ti siedi e scrivi”.
Prima stavo lavando le mutande (a cosa mi sono ridotto) e m’è tornato in mente un episodio risalente a parecchi anni fa – grossomodo, a occhio e croce, alla seconda liceo (classico) – in cui una compagna di classe avendo saputo che io in futuro avrei gradito fare lo scrittore di professione (speranza che mai come negli ultimi tempi è stata ridotta a fuoco fatuo) mi aveva chiesto, appunto, come si facesse a scrivere. Risposta: “Ti siedi e scrivi”.
Il riferimento colto più trasparente è quello del titolo stesso, che riprende quello di un dramma morale del XV secolo in cui l’uomo, ossia Everyman, Ognuno, deve districarsi dalle grinfie della Morte ma, soprattutto, sa che può sconfiggerla soltanto con la salvezza ovvero santità, cioè con la vita eterna. Philip Roth priva il protagonista di questa prospettiva escatologica, mostrandoci la sua completa assenza nella prima scena, in cui la sua figura viene delineata dai discorsi commemorativi, e chiudendo il romanzo con la perdita dei sensi e la frase “Non era più”. Per questo motivo andrà all’inferno, ma non si può negare che, nell’economia narrativa del testo, non ci sarebbe stata soluzione più ragionevole e dovuta.
giovedì 17 maggio 2007
Il modello inglese
(Parentesi francese #1: stamattina Campanellino mi ha fatto sapere che, nonostante lei persista indefessa nello studio, a Parigi oggi è festa. Domando: “Per via di Sarkozy?”; aggiungo: “Se è per questo sarà festa per cinque anni”; risponde: “Stronzetto”. In realtà oggi sarebbe l’ascensione, ossia quaranta giorni da Pasqua, ma la Chiesa Cattolica festeggia alla domenica successiva. Lo stato francese, la cosa più laica che si possa immaginare, pur di contraddirla regala un giovedì libero ai suoi sudditi, pardon, elettori, insomma, ai suoi cosi.)
Voi non avete idea di quant’è incazzato John McDonnell. Per sgomberare il campo da ogni ambiguità, John McDonnell non è il vescovo di Fulham (quanto meno non ancora) ma un deputato laburista che ha deciso di salvare la democrazia candidandosi contro la leadership di Gordon Brown. Non so se sapete come funziona: Blair ha annunziato che si dimetterà il 27 giugno, pertanto il suo partito ha quaranta giorni di tempo, a partire da oggi, per trovare un sostituto. Può candidarsi chiunque abbia raccolto almeno 45 firme di colleghi parlamentari (in tutto sono 352, se non sbaglio), dopo di che ci sarebbe stata una vera e propria campagna elettorale e un voto a cui avrebbero partecipato soltanto i laburisti. John McDonnell, testualmente per amore di democrazia, aveva deciso di candidarsi contro Gordon Brown, ma questi ha sagacemente provveduto a raccogliere 308 firme tutte per sé; ne restano tutt’al più 44, e John McDonnell non potrà sfidare Gordon Brown, e Gordon Brown si candiderà da solo, e il prossimo primo ministro dell’Inghilterra sarà deciso così: votato dagli iscritti a un solo partito all’interno di una rosa di un solo candidato.
(Parentesi francese #2: da ieri mattina mi chiedo dove sia andata la macchina di Chirac, allontanandosi piano piano e vedendo progressivamente rimpicciolirsi, nello specchietto retrovisore, l’immagine di Sarkozy che fa ciao ciao con la manina.)
L’Inghilterra, come buona parte delle nazioni civili (cioè Israele) non ha una costituzione, perché non ne ha bisogno. Il potere politico è nelle mani della Regina, che fino a poco tempo fa non pagava le tasse per la semplice e ragionevole ragione che se le sarebbe pagate da sola, mettendosi nella tasca destra ciò che si sfilava dalla sinistra; la Regina può discrezionalmente nominare un primo ministro, che potrebbe anche essere il suo cagnolino o perfino Giovanni Masotti, ma la prassi è che nomini il capo del partito che ha preso più voti (dettaglio per gli insipienti: l’Italia è una repubblica e come tale si presuppone più democratica, ma il capo del partito che ha preso più voti non è Prodi): non è scritto da nessuna parte; ragion per cui non fa differenza se si diventa primo ministro con trenta milioni di voti o con le firme di trecento parlamentari. Il potere religioso è nelle mani della Regina, che per non avere noie lo subaffitta all’arcivescovo di Canterbury. L’anglicanesimo è religione di Stato (in Italia si blatera di ingerenza ecclesiastica nelle faccende statali e si spediscono proiettili in busta chiusa) e il primo ministro ha il potere di far affiggere l’avviso “Vietato Fumare” sulle colonne di tutte le chiese del Regno. Il vescovo di Fulham ha detto che è un’imposizione inaccettabile, è la goccia che fa traboccare il vaso; il Times stamattina riportava in prima pagina che Blair, non appena disoccupato, si convertirà al cattolicesimo; chissà - magari chi tanti anni fa pregava per la conversione dell’Inghilterra, sta con un po’ di ritardo iniziando a venire esaudito.
lunedì 14 maggio 2007
Come organizzare i propri affetti
Per dire quattro parole e sbagliarle tutte ci vuole indubbiamente un certo talento, che rientra senza dubbio nel (per fortuna di più ampio spettro) novero di talenti della ministra Emma Bonino. La quale un paio di sere fa, durante il Tg1 che cerco di seguire anche da queste piovose latitudini, ha dichiarato che la manifestazione di Coraggio Laico, ossia il piccolo carnevale di piazza Navona, intendeva tutelare i diritti di chiunque volesse scegliere come organizzare i propri affetti. Questo è in grande linee il succo del suo discorso, ma le ultime quattro parole (comprensive di articolo determinativo) sono una citazione testuale, e sono tutte sbagliate.
1. Come – Poniamo caso che la ministra Bonino entri nella libreria QI di Oxford (16 Turl Street, io ci sono passato sabato pomeriggio). Tale libreria è ampiamente applaudita negli ambienti intelligenti perché non cataloga i libri secondo nessun ordine tradizionale: non per autore, non per genere, non per editore, non lo snervante benché funzionale sistema Dewey. La ministra Bonino avrebbe dunque una certa difficoltà a orientarsi e a comperare, ad esempio, Alla Ricerca del Tempo Perduto. Apprenderebbe magari dai commessi che i sette volumi in questione sono così ripartiti: uno nel settore dei romanzi francesi, uno in quello dei classici del novecento, uno fra i capolavori dell’omoerotismo latente, uno fra le autobiografie, uno fra gli scritti di autori coi baffi, uno fra i testi più lunghi di mille pagine e uno fra i libri composti di più volumi. E questo già sarebbe abbastanza razionale, poiché invece lo scopo ultimo della libreria QI, edificata col preciso intento di trovare un’impostazione originale per la catalogazione dei libri, è far venire il giramento di testa ai clienti, cosa cui collabora non poco la sua struttura circolare. Se fosse entrata nella libreria QI di Oxford (16 Turl Street, io non ci andrò mai più), la ministra Bonino avrebbe capito che i DICO sono un’idea marcia come la pretesa di sistemare i libri secondo un ordinamento non codificato – o peggio ancora di codificare un ordinamento irragionevole – e che al confronto il matrimonio, con tutti i suoi difetti, è stabile come l’ordine alfabetico: che farà capitare Luciano De Crescenzo vicino a Don De Lillo, ma almeno ogni cosa è al proprio posto.
2. Organizzare – “Pronto, picci, sono Gurrado, dobbiamo organizzare il nostro affetto.” “Gurrado, ma che minchia dici mai?” “Giuraddio, l’ha detto la ministra Bonino al telegiornale, l’ho sentito con quest’orecchio”. E così via in un gran trambusto di organizzazione d’affetti, dalle fidanzate di là da venire ai passanti che saluto per strada, dagli uffici stampa delle case editrici a chi mi chiama perché ha sbagliato numero, intere caterve di relazioni a ragnatela che vanno ordinate, sistematizzate, classificate. La bizzarria dei DICO è che fanno passare per libertaria (e libertina) una legge che invece cancella ogni poesia dell’indefinito; un’idea stalinista per cui Gurrado e picci devono mandarsi tutta una serie di lettere raccomandate per spiegarsi nei minimi dettagli che relazione intercorre fra le loro due persone giuridiche. Quando un ministro, o una ministra, utilizza il termine organizzare per parlare delle vite private dei suoi elettori, insomma, qualcosa non quadra, non mi sembra che ci sia bisogno di dilungarsi.
3. I propri – Qui casca la ministra, e io mi dilungo. Perché la principale differenza fra il milione all’incirca del Family Day e i tre partecipanti di Coraggio Laico era (beninteso, stiamo parlando dell’idea generale sottesa a ciascuna delle manifestazioni) che i secondi pensano all’orticello di diritti e i primi al giardino di doveri. Non sono così scemo da ritenere che fosse un concetto condiviso da chiunque in Piazza San Giovanni, né tantomeno che ogni manifestante del Family Day abbia vissuto integerrimamente secondo questo principio aureo, ma grossomodo difendere l’esistenza e l’unicità della famiglia (maschietto + femminuccia = bambinelli) significa farla rientrare in un quadro che pieghi la volontà personale e sacrifichi i capricci adolescenziali a un bene comune che si riconosce più alto. Più alto innanzitutto perché – come raffigurato dalla croce che qui sopra unisce il maschietto alla femminuccia – una promessa assume maggior significato se controfirmata dal sovrumano (tradotto, una cosa è dire che Gurrado è unito a picci in nome del Padre del Figlio e dello Spirito, un’altra che Gurrado è unito a picci in virtù delle ministre Bonino, Bindi e Pollastrini). E poi, diciamocelo, se invece di Gurrado io fossi picci mi offenderei non poco all’idea che un uomo, in luogo di implorarmi di vivere con lui per tutto il resto della vita nostra e di promettermelo davanti al Padreterno e di accarezzarmi la pancia per nove mesi di fila, mi proponga un succedaneo progressista che suona grossomodo: “Senti, facciamo che ti mando una raccomandata in cui specifico che tu vivi con me ma sei libera di andartene quando vuoi, che i tuoi figli sono anche miei nella misura in cui sono condivisi [i progressisti parlano così, che volete farci] senza che per questo la nostra conformità genitoriale [idem come sopra] diventi un ostacolo alla loro integrazione nella società sovra-ultra-metafamiliare” – aggiungendo subito dopo: “E tieni presente che ti avrei detto queste precise identiche parole se anche tu fossi un uomo e ti chiamassi Arturo”. Ho amiche che non vogliono sposarsi; ho amiche che non vogliono fare figli; tutte costoro, però, vogliono vivere con un uomo e avere dei bambini. Vogliono la pera e non il torsolo, insomma: temono che il matrimonio le annoi e la gravidanza le sfiguri. Ci vorrebbe oggigiorno un poeta barocco che sorgesse in tutta la propria potenza semantica per spiegar loro che, vabbe’, possono non sposarsi ma non possono non invecchiare, possono non avere figli ma non possono non sfigurarsi, e che tutte le ministre Bonino di questo mondo non potranno preservarle da solitudine e decomposizione. Ci sarebbe voluto magari un sacerdote che ai tempi del catechismo, prima che l’iscrizione all’università e la quotidiana lettura della Repubblica avessero fatto il proprio corso, avesse spiegato a chiari termini che se non si decide di fare qualche passo indietro alla fine nessuno farà veri passi avanti verso di noi.
4. Affetti – Declinazione plurale di un termine debole. La ministra Bonino è intelligente e quindi ha capito mentre ancora parlava alle telecamere che un termine forte avrebbe stonato in conclusione del proprio discorsetto, fondato sull’assolutismo relativistico e volto alla sostituzione di un’opzione temporanea a una scelta definitiva (cosa nella quale c’è ben poco coraggio, laico o meno). La ministra Bonino sa le lingue pertanto non si offenderà se mi permetto di tradurre le sue quattro parole in altrettanti termini forti, che trascendono il senso limitato del suo appello, capovolgendolo: la questione non è come organizzare i propri affetti, ma perché garantire l’amore altrui.
PS per mia madre: picci non esiste.
giovedì 10 maggio 2007
Essere rossi oggi
Immagino che anche in Italia sia arrivata l’eco del bel gesto reso dal Chelsea prima della partita contro il Manchester United. I blu di Londra, secondi alle spalle dei rossi del nordovest, hanno reso omaggio ai freschi vincitori del campionato disponendosi su due file parallele e applaudendo i giocatori avversari mentre uscivano dallo spogliatoio. Ammirevole invero, e immagino i peana che si saranno alzati sulle reti televisive nostrane a magnificare lo spirito olimpico e il modello inglese e fregnacce varie. Se non che non poteva sfuggire il dettaglio che il diabolico Sir Alex Ferguson ha fatto spuntare dagli spogliatoi una squadra farlocca, imbottita di riserve inverosimili – dite la verità, voi lo sapevate che nel Manchester United giocava O’Shea? E Kuzsack? O, peggio ancora, lo sapevate che il cinese Dong, temerariamente schierato come prima punta, fosse pagato per giocare a calcio?
La faccia di John Terry, capitano del Chelsea e della nazionale inglese, era tutta un programma: costretto, poverino, ad applaudire pubblicamente una manica di sconosciuti che sei mesi prima avevano ancora il suo poster appeso in camera. Il diabolico Sir Alex Ferguson (lo stesso che, per intenderci, aveva genialmente staccato il biglietto per Atene prima di giocare la semifinale di ritorno col Milan) avrebbe potuto farla più grossa soltanto facendo comparire sul campo, fra le due ali blu dei plaudenti giocatori del Chelsea, undici manichini con le rotelle (uno a caso dei quali sarebbe tuttavia stato più utile alla squadra del surreale cinese Dong).
La stessa identica cosa è accaduta oggi pomeriggio, quando Tony Blair ha annunciato l’annunciato annuncio del suo ritiro dalla scena politica. I numeri sono tutti dalla sua parte: tredici anni alla guida del Labour, più giovane leader del partito in assoluto, gli ha fatto vincere le elezioni per la prima volta dopo diciott’anni, ne ha vinte tre di fila, ha governato per dieci anni, è stato il più giovane primo ministro della storia inglese a parte lord Liverpool, che comunque aveva come interlocutore privilegiato Napoleone e non Chirac, quindi erano decisamente altri tempi. Perfino agli occhi della politica inglese – molto più snella e ragionevole di quella italiana – la parabola di Blair è apparsa sorprendente e quasi miracolosa, così come sorprendente e miracoloso è stato il titolo vinto quest’anno, più che convincentemente e contro ogni pronostico, dal Manchester United. D’altra parte sempre di color rosso si tratta.
La Storia gli avrebbe dovuto riservare tutt’altro congedo. Se non che oggi pomeriggio, rinchiuso nel suo quartier generale come Hitler nel suo bunker, Tony Blair aspirava a somigliare a Churchill ma sembrava Dong, uno che con suo stesso stupore raccoglie applausi e ovazioni soltanto perché sta indossando per puro caso una maglia e degli onori altrui. Innanzitutto questo benedetto annuncio dell’addio è stato annunciato troppe volte, e dalle elezioni del 2005 non si faceva altro che dire: “Vedrete, si dimetterà nell’estate 2007” – come volevasi dimostrare. Di più, mai come questa volta Tony Blair (che pure ha un passato da attore di teatro) ha sbagliato i tempi rimandando l’inchino – come scriveva il Daily Telegraph stamattina – al momento in cui il pubblico è già andato via e restano solo le cartacce sul pavimento. Per aggiungere la beffa al danno, nel question-time presidenziale di ieri David Cameron, il giovane e bel leader dei giovani e bei conservatori, ha apostrofato il gabinetto Blair come “il governo dei morti viventi”; né si può dargli torto, visto che il primo ministro si sta spegnendo piano piano da un paio d’anni, il ministro degli interni (John Reid) s’è dimesso qualche giorno fa, il ministro dell’Europa Geoff Hoon è l’uomo più sbertucciato dai media inglesi già da quand’era capogruppo nel 2003 – e soprattutto visto che il ministro delle finanze Gordon Brown, successore designato di Blair, viene visto dagli inglesi e dai laburisti stessi come una fetta di bacon negli occhi. Evviva.
David Cameron avrà mille difetti; sarà vanesio, sarà ingenuo, sarà per certi versi troppo entusiasta rispetto ai gusti di queste piovose latitudini; dovrà inoltre prima o poi scontare la pena per essersi fatto propagandisticamente fotografare in metropolitana mentre leggeva l’ultimo romanzo di Ian McEwan (Ian McEwan! In metropolitana! Come se fosse un Veltroni qualunque!). Tuttavia bisogna dargli atto che un anno e mezzo fa, intervenendo nel suo primo question-time presidenziale, inchiodò Tony Blair alla profezia che oggi si realizza, e che recitava: “You were the future once”, “Lei era il futuro di tanto tempo fa”. Ieri pomeriggio, se non avesse avuto pietà, gli avrebbe anche potuto dire: “Lei è come il Manchester United, festeggia il campionato dopo aver parlato per mesi della Champions League”.
(Nota per i patrioti: sottolineo come questi pochi capoversi avrebbero agevolmente potuto essere dedicati al parallelo fra l’ambrosiana Inter, che manifesta la propria schiacciante superiorità perdendo 6-2 con la Roma, e il governo in carica che ribadisce la propria saldezza squacquerandosi nel giro di ventiquattr’ore su pensioni e famiglia. Avrei potuto, e molto facilmente; ciò nondimeno, poiché fra qualche mese dovrò pur trovar lavoro, non l’ho fatto: quindi, Romano, ricordati degli amici!)
lunedì 7 maggio 2007
Il Caimano al contrario
Direte: tutto questo casino per un biglietto del metrò? Tutto questo casino per 33 euri di multa a chi calpesta le sacre aiuole del Luxembourg? No, tutto questo per dimostrare che mai come questa volta le elezioni francesi hanno spaccato il capello in quattro. Da un lato, infatti, si sono trovati quelli che hanno un’idea indefettibile della legge (ossia: le aiuole non si calpestano; in metrò si fa il biglietto; e così via), e che hanno un ideale di ordine, di pragmatismo, di meritocrazia – per usare le parole stesse di Sarkozy.
E dall’altro lato? Dall’altro lato si sono trovati i sedicenti difensori della democrazia, quelli per cui se un giovanotto senza biglietto nel metrò è nero o beur bisogna lasciarlo andare, o se i poliziotti ti fischiano dietro mentre stai facendo jogging sull’erba del Luxembourg esercitano un’indebita ingerenza e usano violenza ai tuoi illimitati diritti di cittadino progressista. Per costoro, la vittoria di Sarkozy avrebbe significato la fine della democrazia in Francia, l’imposizione di uno stato di polizia, probabilmente l’inizio di uno stato di agitazione permanente nelle periferie. L’articolo di Nabila Ramdani, scritto ventiquattr’ore prima dei risultati, titolava minacciosamente: La ribellione inizierà quando verrà eletto.
Con buona pace della ribelle Ramdani e di tutti quelli come lei, Sarkozy ha vinto e da circa venticinque ore, com’è sotto gli occhi di tutti, la Francia agonizza sotto i colpi di un’atroce dittatura, nella quale a quanto si dice i poliziotti, les flics, sono giunti a sentirsi in diritto di far rimuovere delle automobili parcheggiate in divieto di sosta. Mi chiedo quanto ancora il popolo francese potrà resistere a simili abusi.
No, davvero. Quando ero andato a vedere Il Caimano, oltre a trovarlo un film ben fatto come d’altronde tutti quelli di Nanni Moretti (non un’ombra d’ironia su questa frase, ci tengo a sottolinearlo) mi era piaciuto in particolar modo il finale. Mi era piaciuto narratologicamente, intendo, con gli incendi che divampavano appiccati da una folla plagiata dal potere mediatico del Caimano, e che di fatto tentava di rovesciare con la ribellione la sentenza con la quale la giustizia ordinaria aveva condannato il medesimo (parentesi: in Inghilterra è giunta voce che Berlusconi sia stato assolto nel processo SME; se Nanni Moretti ha tempo sarei felice che mi telefonasse per confermarmi che è vero). Me ne sono ricordato vivamente ieri sera quando Sarkozy, l’uomo pericolosissimo per la democrazia, era stato democraticamente eletto da poche ore e i sostenitori della democrazia caricavano la polizia, bruciavano il tricolore francese, incendiavano motorini. Le fiamme nella notte, fotografate sul sito del Corriere, sembravano le stesse del Caimano; solo che nella circostanza erano contro il Caimano di turno, e quindi erano fiamme giuste, erano motorini immolati in difesa della democrazia, quindi niente da eccepire.
(Fra parentesi, oggi Campanellino che è tanto carina ma è un po’ comunista mi ha fatto notare che, mannaggia a me, dopo il mio Papa preferito sono riuscito a far eleggere anche il mio presidente francese preferito! Dettaglio non da poco, Campanellino ora come ora vive a Parigi e per quanto io sia sicuro che non calpesta l’erba del Luxembourg non ritengo che abbia motivo di rallegrarsi quanto me per i risultati elettorali. Le ho risposto che a quanto pare i miei poteri parapolitici funzionano soltanto sulle elezioni all’estero (Stati Uniti, Francia, Vaticano – per non parlare delle comunali in Inghilterra giovedì scorso, coi Conservatori al 40%), ma non in Italia. Oppure vuol dire che solo e soltanto in Italia le elezioni non vengono ammantate della luce dello Spirito Santo (a differenza di quello che accade in Vaticano, Francia, Inghilterra e ovviamente Stati Uniti), e che quindi l’Italia è - se non ce ne siamo accorti ancora – fuori dalla grazia del Signore. Chiusa la parentesi.)
Purtroppo l’Observer esce una volta a settimana e quindi dovrò aspettare almeno fino a domenica prossima per leggere un articolo in cui la Ramdani o chi per lei spiegherà che i tumulti a Parigi, Marsiglia, Lione, Lille, Nantes e Dio solo sa dove altro sono una sdegnata reazione spontanea all’ennesimo atto provocatorio e prevaricatore compiuto da Sarkozy, il quale ha creduto di poter vincere le elezioni pur essendo manifestamente dalla parte del torto, lui e tutti i poliziotti che vogliono far pagare il biglietto del metrò. Corollario finale vietato ai minori di anni 18: i progressisti, quando hanno un’idea, ritengono che sia necessariamente giusta esattamente come talune signorine, una volta scoperto di avere soltanto una fica, concludono indebitamente di avercela soltanto loro.
sabato 5 maggio 2007
"Do you have the pink italian newspaper?"

giovedì 3 maggio 2007
Diciott'anni non passano invano
Io invece la so lunga e ho capito che il Milan si sarebbe qualificato (stavo scrivendo: che ci saremmo qualificati, ma in tempi di trionfalismo è sempre bene tenere un certo distacco) quando Sir Alex Ferguson s’è fatto intervistare tre volte da ITV, una all’inizio, una alla fine e una fra il primo e il secondo tempo della partita d’andata. Sarà che, come mi hanno spiegato, è una tradizione locale e un gesto di educazione e rispetto nei confronti di giornalisti e tifosi, ma come linea di condotta generale io, se sto facendo una cosa importante, evito di fermarmi ogni mezz’ora per spiegare all’universo mondo cosa sto facendo, e come la sto facendo, e perché la sto facendo.
No, anzi: ho capito che ci saremmo, cioè, che il Milan si sarebbe qualificato quando prima ancora che la gara d’andata finisse, anzi, prima ancora che il Manchester United pareggiasse e credesse di aver raddrizzato un destino storto e nodoso, quando un anglico bianco e rosso seduto sul divano dietro al mio s’è lasciato commentare il compiaciuto commento (che traduco): “Ah, mi ricordo quando alla domenica pomeriggio Channel4 trasmetteva la Serie A”, per poi lasciarsi andare a un nostalgico urlo che, se non fossi già stato scosso nell’animo dagli eventi on pitch, mi avrebbe fatto sperare che o il mio o il suo divano sprofondasse: "Gooooolllllaaaaaassssssooooooo!”.
Ora che uno, per quanto inglese, sia convinto che in Italia i cronisti urlino in questa maniera, e che di conseguenza l’Italia e per soprammercato la Francia siano in fin dei conti uguali alla Spagna, al Portogallo e pure al Brasile decisamente non conosce l’avversario; e chi, per presunzione, non conosce l’avversario, necessariamente merita la sconfitta. Alla stessa maniera una settimana intera di dichiarazioni entusiastiche dei sostenitori del Manchester United sui giornali inglesi, alcuni dei quali sono seri, e soprattutto da parte del gracile biondino con la pinta di birra in mano non aveva fatto altro che confermarmi che questi non avevano ancora ben capito contro cosa, e contro chi, stavano per schiantarsi.
Novanta minuti a San Siro sono molto lunghi. Lo sanno bene i tifosi del Milan, soprattutto quando costretti a guardare degli squallidi 0-0 contro squadre indegne nei turni più inutili di campionato. Ma lo sanno meglio ancora gli avversari che il Milan ha via via fatto capitolare nella sua lunga e gloriosa storia europea, talmente lunga e talmente gloriosa che soltanto un interista si azzarderebbe a dire il contrario. Un esempio per tutti è il Real Madrid, che nel maggio 1989 si sentì forte del pareggio (1-1 in casa!) dell’andata e venne a San Siro per fare la mezza partita cosiddetta, sperando nell’episodio rocambolesco che li avrebbe catapultati in finale per l’inerzia del blasone. Risultato? Ancelotti, Gullit, Rijkaard, Van Basten e Donadoni: 5-0.
All’andata il Manchester United ha dimostrato che, quando si tratta di invadere in forze una città nemica, non hanno eguali e alla fine la spuntano comunque; al ritorno il Manchester United ha scoperto che entrare coi carri armati è facile, scendere dai carri armati no. Per il corpo a corpo di ieri sera, che mi aveva reso talmente nervoso da farmi inserire in mattinata un intero paragrafo su Gullit nella mia tesi riguardante Voltaire e la teocrazia ebraica, ho preparato le armi decidendo per il silenzio e il profilo basso. Mica per niente: ero seduto in mezzo a cinquanta inglesi di vario sesso (talvolta indistinguibile) e di varia dimensione. C’era il gracile biondino che, per quanto canna al vento, una pinta vuota poteva tirarmela appresso. C’era Mister Gollasso, che ha urlato molto meno di quanto si aspettasse. E c’ero io, l’unico italiano, l’unico milanista, l’unico a stare seduto in silenzio come se fosse a teatro.
Il profilo basso è finito all’undicesimo del primo tempo: quando abbiamo, cioè, quando Kakà ha segnato io sono scattato in piedi a braccia divaricate e pugni chiusi verso il basso, urlando anzi ruggendo parole che, essendo in Italiano, mi hanno garantito di sopravvivere. Poi mi sono guardato attorno e ho visto cinquanta inglesi, tutti seduti, tutti immobili, tutti zitti in un silenzio carico di rimprovero. Avrei dovuto mormorare delle scuse, poiché in fin dei conti sono ospite, ma poi ho pensato: scusate ’sta minchia, è la legge del più forte.
A poco a poco hanno ripreso coraggio ed ecco che nuovamente io nuovamente mi sono trovato in piedi a vedere Seedorf che raddoppiava e a pronunziare parole delle quali non comprendevo il senso e che probabilmente sono contenute nel libro dell’Apocalissi mentre una lingua di fuoco rossa e nera mi ornava il capo. Al terzo goal, mi usciva il fumo dalle narici e invece di esultare protestavo contro il cronista che per tutto il tempo aveva parlato di Gilardino come Gilardinho, pronunziandolo Gilardigno.Poi la linea è tornata allo studio. Io mi sono accasciato sulla mia poltroncina, stanco morto come se avessi giocato io; la lingua di fuoco si è ritirata, il fumo ha smesso di uscirmi dalle narici e avevo perfino dischiuso i pugni, restando coi segni delle unghie sul palmo delle mani. Gli inglesi, andandosene a poco a poco a meditare sui propri errori e a chiedersi se meglio non fosse non essere mai nati, non hanno potuto accorgersi che in tv la linea tornava allo studio e che, a commentare il dopopartita per sky, ci foss Ruud Gullit. Io me ne sono accorto invece, e ho pensato che – Ancelotti, Gullit, Seedorf, Kakà e Berlusconi – in fin dei conti non è cambiato molto, speriamo.
mercoledì 2 maggio 2007
Il circolo Belsey